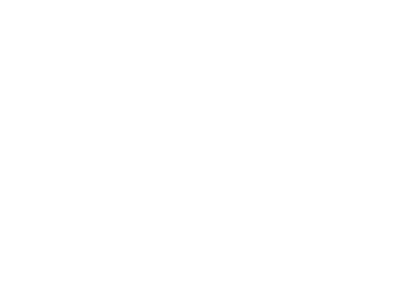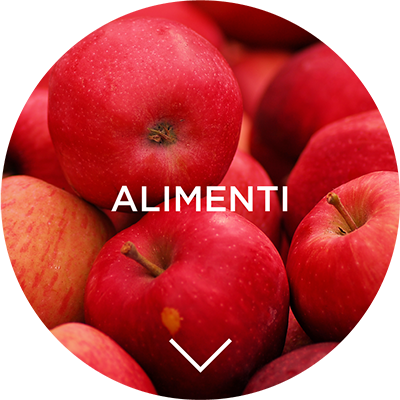Sonestedt E., Lukic M.
Food Nutr Res. 2024 Apr 2;68.
Bevande: una revisione dell’ambito per le raccomandazioni nutrizionali nordiche 2023
Sfondo:
Caffè, tè, bevande zuccherate (SSB) e bevande zuccherate a basso contenuto calorico e senza calorie (LNCSB) sono generalmente frequentemente consumate nei paesi nordici e baltici. Queste bevande sono state anche correlate a potenziali effetti sulla salute.
Questa revisione descrive le prove del ruolo di caffè, tè, SSB e LNCSB per gli esiti relativi alla salute come base per la definizione e l’aggiornamento delle linee guida dietetiche basate sugli alimenti.
Sono state utilizzate le evidenze di diverse revisioni sistematiche qualificate (ad esempio il World Cancer Research Fund, il Comitato consultivo per le linee guida dietetiche degli Stati Uniti, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e l’Organizzazione mondiale della sanità) e sono state eseguite ricerche di ulteriori revisioni sistematiche.
L’evidenza suggerisce che il consumo moderato di caffè e tè non ha effetti negativi sulla salute a lungo termine. Gli effetti favorevoli a lungo termine del consumo di caffè sono legati alla riduzione del rischio di cancro dell’endometrio e del fegato, diabete di tipo 2 e morte cardiovascolare.
Tuttavia, i risultati di studi randomizzati controllati (RCT) suggeriscono che gli infusi di caffè ricchi di diterpeni, come il caffè bollito, aumentano le concentrazioni sieriche di colesterolo.
Un’elevata assunzione di caffeina in gravidanza è associata a un rischio più elevato di aborto spontaneo, parto pretermine e basso peso alla nascita.
L’elevato consumo di SSB è stato associato ad un aumento del rischio di obesità, diabete di tipo 2, ipertensione e malattie cardiovascolari, sulla base dei dati degli RCT e degli studi prospettici di coorte.
Il consumo di LNCSB può comportare una piccola riduzione del peso corporeo negli adulti, probabilmente mediata dall’effetto di un ridotto apporto energetico, ma ha effetti neutri su altri marcatori di rischio cardiometabolico utilizzando evidenze da RCT. Tuttavia, le evidenze degli studi osservazionali indicano un aumento del rischio di malattie cardiometaboliche tra i consumatori di LNCSB elevato.
In conclusione,
le prove attuali suggeriscono che il consumo moderato di caffè e tè non ha effetti negativi sulla salute a lungo termine.
L’evidenza degli effetti benefici del consumo di caffè sul rischio di cancro al fegato e all’endometrio, e alcuni esiti cardiovascolari, proviene da studi osservazionali. Un elevato consumo di caffè bollito dovrebbe essere evitato a causa dell’effetto negativo sul profilo lipidico. Le donne in gravidanza non devono superare la dose giornaliera raccomandata di assunzione di caffeina di 200 mg fissata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare come livello sicuro per il feto. L’elevato consumo di SSB è stato costantemente associato a effetti negativi sulla salute, dovuti principalmente all’eccessivo apporto energetico, e dovrebbe essere limitato. I risultati contrastanti degli RCT e degli studi osservazionali riguardanti le LNCSB possono essere dovuti a una causalità riverita e dovrebbero essere esplorati ulteriormente.
Abstract
Beverages – a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023
Background:
Coffee, tea, sugar-sweetened beverages (SSBs), and low- and no-calorie sweetened beverages (LNCSBs) are generally frequently consumed in the Nordic and Baltic countries. These beverages have also been related to potential health effects.
This scoping review describes the evidence for the role of coffee, tea, SSBs, and LNCSBs for health-related outcomes as a basis for setting and updating food-based dietary guidelines.
We used evidence from several qualified systematic reviews (i.e. World Cancer Research Fund, US Dietary Guidelines Advisory Committee, European Food Safety Authority, and World Health Organization) and performed a search for additional systematic reviews.
The evidence suggests that moderate coffee and tea consumption do not have long-term adverse health effects. The long-term favorable effects of coffee consumption are related to reduced risk of endometrial and liver cancer, type 2 diabetes, and cardiovascular deaths.
However, results from randomized controlled trials (RCTs) suggest that coffee brews that are rich in diterpenes, such as boiled coffee, increase serum cholesterol concentrations.
High caffeine intake in pregnancy is associated with higher risk of pregnancy loss, preterm birth, and low birth weight.
High consumption of SSBs has been associated with increased risk of obesity, type 2 diabetes, hypertension, and cardiovascular disease, based on data from RCTs and prospective cohort studies.
The consumption of LNCSBs may result in a small reduction in body weight in adults, likely mediated through the effect of reduced energy intake, but has neutral effects on other cardiometabolic risk markers using evidence from RCTs. However, evidence from observational studies indicates increased risk of cardiometabolic diseases among high LNCSB consumers.
In conclusion,
current evidence suggests that moderate coffee and tea consumption have no long-term adverse health effects.
The evidence of beneficial effects of coffee consumption on liver and endometrial cancer risk, and some cardiovascular outcomes, comes from observational studies. High consumption of boiled coffee should be avoided due to negative effect on lipid profile. Pregnant women should not exceed the recommended daily dose of caffeine intake of 200 mg set by the European Food Safety Authority as a safe level for the fetus. High consumption of SSBs has consistently been associated with adverse health effects, which is mainly due to excess energy intake, and should be limited. The conflicting results from RCTs and observational studies regarding LNCSBs may be due to revere causation and should be explored further.
Link all’articolo originale: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38571923/